.jpg) Dove il tempo si è fermato
Dove il tempo si è fermato
Dietro le sbarre e i cancelli del carcere, l’angoscia di una vita sospesa
di Vincenzo Balzani
professore emerito di Chimica generale all’Università di Bologna
I tempi del tempo
Shakespeare ha scritto che «Il tempo va diversamente a seconda delle persone: io potrei dirvi con chi va al passo, con chi va al trotto, con chi al galoppo, e con chi sta fermo». A volte accade, però, che chi vorrebbe galoppare nel tempo, perché è «la cosa più preziosa che un uomo può spendere» (Teofrasto), può trovarsi in una situazione in cui non gli è possibile farlo; e allora il tempo, anziché «volare veloce come un uccello, scivola lento come un verme» (Ivan Sergeevic Turgenev). È la situazione in cui si trova chi è in carcere.
In carcere, spazio e tempo, le due dimensioni nelle quali può manifestarsi la libertà dell’uomo, sono bloccate. Una condizione molto difficile da sopportare, come dimostrano i 518 suicidi registrati nelle carceri italiane dal 2002 al 2012.
Solo da poco sono venuto a contatto con questo mondo. Nel giugno scorso un amico diacono, che da tempo frequenta come volontario il carcere della Dozza a Bologna, mi disse che fra i detenuti ce n’era uno che voleva iscriversi al primo anno del corso in Chimica industriale e che per superare il test di ingresso aveva bisogno di aiuto. Senza pensarci tanto, gli dissi che io sarei stato felice di aiutarlo. Mi iscrissi così fra i volontari e, terminata la pratica, entrai in carcere per la prima volta venerdì 19 luglio, accompagnato dal mio esperto amico. Mi sembrava di essere al primo giorno di scuola.
 Un cancello dopo l’altro
Un cancello dopo l’altro
Per entrare nel sovraffollato carcere della Dozza (470 posti, 916 detenuti) ci si presenta ad uno sportello esterno della portineria dove, attraverso un vetro antiproiettile e una piccola fessura, si dialoga con una guardia carceraria; accertata l’identità della persona, la guardia compila la prima parte di un modulo che viene consegnato, con un badge, al visitatore. Si entra attraverso una porta di ferro che subito si richiude, si lascia il cellulare in un armadietto e si esce da un’altra porta di ferro. Dopo avere attraversato un grande cortile, superando tre cancelli automatici comandati da lontano dalle guardie, si giunge ad una portineria più interna dove il modulo ricevuto all’entrata viene controllato e compilato in una seconda sezione.
Si entra poi, attraverso un cancello, in un lungo corridoio interrotto ogni tanto da altri cancelli, quindi si passa in un secondo corridoio e si arriva, sempre attraverso cancelli automatici a controllo remoto, davanti ad una postazione di guardie; finalmente si giunge ad un cancello che dà accesso ad una scala. Si arriva così al primo piano del settore giudiziario, che è la mia destinazione. Si accede al piano attraverso un ultimo cancello (il tredicesimo) non più automatico, ma aperto e chiuso manualmente da una guardia con una grande chiave, come si vede nei film. Entrati, si consegna il modulo al capoposto e si chiede di poter vedere il detenuto, che deve essere individuato e chiamato fuori dalla sua cella. Questo “viaggio” all’interno del carcere a volte richiede tempi molto lunghi perché alcuni dei corridoi da percorrere sono temporaneamente chiusi a causa del transito di detenuti, oppure perché le guardie addette all’apertura-chiusura dei cancelli sono occupate in altre mansioni.
Può anche accadere che, arrivati al braccio dove è recluso il detenuto, l’incontro non possa avvenire per vari motivi: il detenuto può non essere in cella, ma all’ora d’aria o di turno per pulizie, o anche perché la “saletta” degli incontri, una piccola camera con una vecchia scrivania e due sedie scassate, è già occupata per un altro colloquio. In questi casi non rimane che tornare all’uscita, attraverso i tredici cancelli. Poiché abito a quaranta chilometri da Bologna, un incontro mancato equivale a un’intera mattina sprecata. Per uno come me, che è abituato a pianificare ed utilizzare il tempo, «l’unico, vero capitale che un essere umano ha, l’unico che non può permettersi di perdere» (Thomas Edison), ritrovarsi alla fine della mattinata senza aver concluso nulla è una vera “prova” di pazienza.
Una volta entrati nella saletta dove ha luogo l’incontro, in attesa che venga condotto il detenuto si può guardare fra le sbarre della finestra. Si vede un cortile asfaltato, circondato da alte pareti di cemento: è uno dei tanti cortili dove i reclusi passano l’ora d’aria. Mi è capitato più volte di osservare l’ora d’aria: uno spettacolo che stringe il cuore. Quasi tutti i detenuti camminano svelti, avanti e indietro da una parete all’altra del cortile, per rimediare alle molte ore di inattività trascorse nelle celle. Spesso camminano a coppie o in piccoli gruppi, parlando. Per questi detenuti l’ora d’aria è un duplice, sia pur limitato, sollievo: aumenta lo spazio vitale e fa passare il tempo. C’è però anche chi cammina lentamente da solo e chi, da solo, siede in un angolo del cortile: per queste persone anche nell’ora d’aria il tempo continua a scorrere più lento del ticchettio degli orologi che lo vogliono misurare.
Il signor G
Il detenuto che ho aiutato a superare il test di ingresso (svolto in carcere) e che continuo a visitare una volta alla settimana si chiama G.; è un ragazzo iraniano che ha superato la trentina, con un trascorso di perseguitato politico. Ha diritto d’asilo in Italia, ma è finito in carcere per detenzione di quantità di droga superiore al quantitativo stabilito dalla legge Giovanardi-Bossi. È una persona gentile ed educata, profondamente toccata da quanto gli è capitato. Come tutti i detenuti che si trovano in carcere per droga, più di
G. mi parla spesso del tempo che non passa. Un proverbio dice che «chi ha da fare non ha tempo per le lacrime». I carcerati, non avendo nulla da fare, di tempo per le lacrime ne hanno tanto, anche se per pudore cercano di non mostrarle. G. ora si è iscritto al corso di laurea in Chimica industriale e spera di riuscire a laurearsi; ma è perfettamente consapevole che, finché non uscirà dal carcere, dove deve scontare una condanna di quattro anni, non potrà fare molta strada, anche perché diversi esami richiedono esercitazioni di laboratorio che non può frequentare. Io non voglio disilluderlo. Gli ho portato tutti i libri dei corsi del primo anno, gentilmente offerti dalla casa editrice Zanichelli, e una volta alla settimana studiamo qualcosa assieme. Gli do anche compiti da svolgere fra un incontro e l’altro, in modo che si accorga meno del tempo; perché, come ha scritto Richard Feynman, «Il tempo è ciò che accade quando non accade nient’altro».
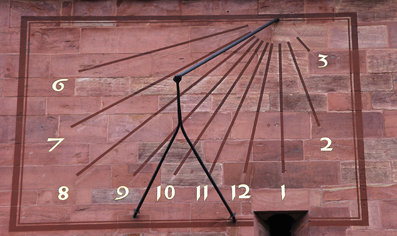 Nota aggiuntiva sulla situazione carceraria in Italia
Nota aggiuntiva sulla situazione carceraria in Italia
Secondo i dati forniti dal Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, al 31 agosto 2012 i detenuti reclusi nei 206 istituti di pena italiani erano
C’è chi sostiene che il problema del sovraffollamento delle carceri vada risolto aumentando i posti disponibili ed infatti sono in corso di apertura o in costruzione carceri per un totale di 12.000 nuovi posti previsti nel 2016, che però non sarebbero ancora sufficienti. C’è invece chi sostiene che il sovraffollamento vada risolto con provvedimenti svuota-carceri come amnistia ed indulto, ma l’esperienza mostra che si tratta solo di provvedimenti tampone. Quello che serve è in realtà qualcosa di più basilare.
Un primo passo può essere la depenalizzazione dei reati minori. Attualmente più di 25.000 persone sono detenute per droga. Di queste, 18.753 sono piccoli spacciatori e consumatori beccati con quantità al di sopra di quella ritenuta per uso personale dalla legge Giovanardi-Bossi. Queste persone andrebbero tolte dal carcere ed assegnate a comunità di recupero per il loro reinserimento sociale attraverso lavori socialmente utili sotto debito controllo. Ma nel nostro Paese i finanziamenti per risolvere i problemi sociali sono sempre più ridotti.
A monte del sovraffollamento carceri c’è il problema più grave della nostra società: la disuguaglianza. Un’indagine condotta dall’associazione inglese The Equality Trust (www.equalitytrust.org.uk), estesa a molte nazioni, ha dimostrato che i problemi sanitari e sociali sono tanto più gravi quanto più grande è la disuguaglianza di reddito (si noti: non il valore del reddito nazionale medio, ma la disuguaglianza di reddito all’interno della nazione). Questo vale per gli omicidi, i furti, l’uso di droghe, l’alcolismo e, quindi, il numero di carcerati. L’Italia, purtroppo, è uno dei Paesi dove maggiore è la disuguaglianza di reddito. Proprio di qui bisognerebbe partire per ridurre i problemi sanitari e sociali, incluso il troppo alto numero di carcerati.
I Paesi con minor numero di carcerati, circa 50 ogni 100.000 abitanti contro i 112 dell’Italia, sono Giappone e paesi scandinavi, caratterizzati da disuguaglianze di reddito molto minori di quelle che si hanno in Italia. I risultati dell’indagine mostrano che ridurre la disuguaglianza di reddito comporta benefici sociali per tutti, anche per i ricchi, e indica due vie per raggiungere questo obiettivo: tassare di più i redditi alti, come accade nei paesi scandinavi, oppure diminuire alla fonte la forbice degli stipendi, come accade in Giappone. Forse è il caso che questi concetti si facciano strada anche nel nostro Paese.
