Durante il convegno-laboratorio “Per una missio ad gentes con sguardo nuovo”, a San Martino in Rio (17-19 aprile), incontro il prof. Ambrogio Bongiovanni, professore di Missiologia e Dialogo interreligioso presso la Pontificia Università Gregoriana, direttore del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana e Presidente della Fondazione MAGIS, l’opera missionaria della Provincia Euro-Mediterranea dei gesuiti e con un’esperienza trentennale in India ed altri paesi del subcontinente indiano nel campo della cooperazione. In una pausa degli intensi lavori, mi è stato possibile rivolgergli alcune domande.
a cura di Saverio Orselli
Missionari o dimissionari?
L’origine nel Padre, la responsabilità di ogni figlio
Intervista ad Ambrogio Bongiovanni
a cura di Saverio Orselli
 Per cominciare vorrei chiederle una definizione di missionarietà.
Per cominciare vorrei chiederle una definizione di missionarietà.
Dobbiamo partire da una ricomprensione della ‘missionarietà’ sviluppata durante il concilio Vaticano II
e, in parte, anche prima, dove la missione della Chiesa è legata essenzialmente alla Missio Dei, cioè alla missione di Dio, per cui ha un’origine trascendente. Nel concilio Vaticano II, nel decreto sull’attività missionaria ad gentes, si esplicita proprio la natura essenzialmente missionaria della Chiesa che ha l’origine, la sua sorgente, in Dio Trinità: in Dio Padre che invia il Figlio. L’azione dello Spirito Santo, a sua volta, guida la Chiesa affinché testimoni il vangelo di Cristo e diventi segno e sacramento di unità per tutto il genere umano. Quindi la missione della Chiesa è orientata e guidata dalla Missio Dei, un’origine divina che muove tutto verso questo rigenerare e ricreare relazioni armoniche con Dio, dell’umano con Dio. In questo discorso perciò la Chiesa non fa la missione ma è la missione che fa la Chiesa. Possiamo dire dunque, riprendendo il paragrafo 2 del documento Ad Gentes, che la natura stessa della Chiesa è missionaria.
 La missione ad gentes sembra superata e i missionari disponibili a partire per andare a evangelizzare ormai si contano sulle dita di una mano: cosa è successo?
La missione ad gentes sembra superata e i missionari disponibili a partire per andare a evangelizzare ormai si contano sulle dita di una mano: cosa è successo?
C’è sempre la tendenza a delegare il compito della missione ad alcuni ‘specialisti’, che vivono in maniera particolare il carisma della missione verso coloro che non conoscono Cristo, secondo la comprensione del termine ad gentes, ma si dimentica che il battesimo che riceviamo come cristiani ci orienta verso una testimonianza della fede che non si limita solo al nostro contesto, ma deve avere la preoccupazione di raggiungere tutti i confini della terra. Nella nozione di Missio ad gentes, la preposizione ad sta a significare questo movimento di uscita, questo moto verso qualcuno per annunciare il vangelo, la buona notizia. Il come interpretare questo e come comprendere chi è l’altro sono determinanti e devono essere una preoccupazione fondamentale di tutta la Chiesa, perché ciò non è altro che espressione della preoccupazione di Gesù stesso, cioè del Logos incarnato. Perché Dio Padre invia il Figlio, Logos incarnato? Egli è una Parola rivelatrice dell’amore di Dio, parola viva, incarnata tra gli uomini… una Parola di salvezza non esclusivista ma offerta a tutti. Da questo esempio e dall’invito di Gesù stesso comprendiamo che la missio ad gentes è cooperare alla missio Dei ed è responsabilità di tutta la Chiesa, di ciascun cristiano.
Purtroppo questo movimento ad gentes oggi corre il rischio di essere un po’ svalutato, per via di una preoccupazione anche lecita, legata alla storia della missione e a come essa è stata attuata. Penso cioè alla preoccupazione affinché la missione della Chiesa oggi superi quell’approccio esclusivista o addirittura colonialista che a volte nel passato l’ha caratterizzata. Pur raccogliendo tale preoccupazione, non si deve correre il rischio di perdere il significato teologico più profondo di questo movimento, che nasce da Dio stesso, che esce da sé per andare incontro a tutta l’umanità, alle sue creature e manifestarsi nell’amore. Oggi occorre anche precisare meglio cosa comporti questo movimento, come debba essere fatto, chi sono le “genti”, chi sono i nostri interlocutori, chi è per noi l’altro da incontrare. Per comprendere tutto questo dobbiamo fare ricorso al linguaggio, non solo verbale, che Gesù ha usato, al suo modo di vivere la missione che gli era stata affidata dal Padre e poi all’intervento dello Spirito nella comunità degli apostoli e dei discepoli, a partire dalla Pentecoste.
C’è una missione chiaramente ad gentes di Gesù, che predica il Regno di Dio aperto a tutti, rivolto a tutti, fino ai margini della società, “fino agli estremi confini”. E poi lo Spirito che orienta la Chiesa a partecipare alla missio Dei, spingendo gli apostoli ad uscire da una dimensione chiusa e ad abbandonare il clima di preoccupazione che c’era all’interno della comunità, che ancora non aveva assorbito, nonostante la Risurrezione, il senso di sconfitta e smarrimento per la morte di Gesù. Il libro degli Atti ci presenta questa iniziale resistenza umana a muoversi, ma lo Spirito Santo, continuando l’azione di Dio, spinge con forza quella Chiesa primitiva verso un movimento di uscita. Quel movimento che Papa Francesco in Evangelii Gaudium riprende con la bellissima espressione di “Chiesa in uscita”. Quando diciamo Chiesa, dobbiamo tutti superare la logica di pensare solo all’istituzione. La Chiesa che il Concilio ci ha consegnato è una realtà che si traduce nell’appartenenza personale, nell’impegno individuale e comunitario, nel cammino nel mondo, dove ogni battezzato è parte attiva. Nella missio ad gentes dobbiamo riprendere questo tema e sentirlo come una dimensione che coinvolge tutti.
 In passato, il missionario creava anche tante strutture: come stanno le cose oggi?
In passato, il missionario creava anche tante strutture: come stanno le cose oggi?
Oggi la realtà è cambiata molto. Un tempo si aveva la sensazione di una missione che partiva dal centro (generalmente i paesi europei) verso una periferia lontana e quindi il missionario o la missionaria erano coloro che partivano fisicamente da tale centro, da una Chiesa che viveva essenzialmente nella parte nord del mondo e che inviava qualcuno verso luoghi lontani. Oggi siamo in un’altra fase, in cui molte volte le Chiese locali del sud del mondo sono ben sviluppate, hanno una loro autonomia, per cui il missionario (che difatti non è più solo marcatamente occidentale) è colui che si incarna in un contesto e si offre come segno di quella dimensione missionaria di tutta la Chiesa universale. Egli porta come testimonianza proprio questo movimento d’amore; in un certo senso, mostra questa dimensione della comunione di tutta la Chiesa, di corresponsabilità di tutta la Chiesa… e di questa comunione in Dio. Le opere sociali non sono altro che una dimensione della missione che riguarda il dialogo con i poveri, l’opzione preferenziale dei poveri. Anche teologicamente i poveri hanno un ruolo importante, sono una categoria che potremmo dire teologica e quindi questa opzione preferenziale non è solo una questione materiale.
È ancora una volta il linguaggio di Gesù che si rivolge ai poveri e capovolge la logica umana: quei poveri sono ricchi in effetti dell’amore di Dio, sono ricchi di una presenza di Dio e quindi, a loro volta, diventano testimonianza di questo incontro. Le opere sono importanti, perché la missione della Chiesa è anche una missione di liberazione da tutto ciò che ostacola la rivelazione di Dio, come le strutture di peccato: dietro ogni forma di povertà ci sono sempre forme di ingiustizia. Dio ci ha detto che i poveri sono un luogo in cui Lui si manifesta e, se tra i poveri troviamo la presenza di Dio, allora è proprio lì che dobbiamo curare l’aspetto della giustizia. Dio vuole che ci sia salvezza, che ci sia un intervento di liberazione dall’oppressione e che la promozione del Regno parta da qui. La nostra è anche una missione di riconciliazione, che incontra e cura le persone, ma anche di giustizia e quindi le opere sono importantissime perché mostrano questa vicinanza e, nello stesso tempo, mettono in risalto lo squilibrio che c’è, la disarmonia che c’è per poi costruire riconciliazione.
Il dialogo interreligioso è un nuovo modo di interpretare il mandato missionario che coinvolge ogni cristiano?
Quando parliamo di dialogo interreligioso dobbiamo chiarire che cosa intendiamo. Io ne parlo soprattutto in termini di dialogo tra le persone, più che tra le religioni. Troppo spesso si preferisce un’interpretazione un po’ astratta, mentre io preferisco scendere sul terreno della vita: il dialogo interreligioso è possibile quando ci sono partner in dialogo attivi su questo processo. Partner che possono essere leaders, teologi o persone normali, che vivono a diversi livelli questo dialogo. Il dialogo interreligioso lo intendo essenzialmente come dialogo “religioso”, cioè tra persone credenti, tra persone che si rivolgono a un Creatore, che hanno una relazione con il trascendente. Questo è un punto fondamentale. In questo senso, il dialogo interreligioso è parte integrante della missione della Chiesa. In tutto il discorso della missio ad gentes, è vero che c’è la componente dell’annuncio che non può essere trascurata, ma c’è anche la componente dialogica, cioè comprendere l’altro.
Il dialogo interreligioso ci permette di incontrarci, non mettendo tra parentesi la nostra fede. Dialogo e annuncio sono infatti aspetti connessi tra di loro, ma che appartengono all’unica missione della Chiesa. Il dialogo interreligioso nel nostro tempo lo stiamo ricomprendendo e attuando anche e soprattutto a livello di base, mentre prima era visto essenzialmente in una prospettiva teoretica per gli addetti ai lavori, per i teologi o per i missionari che lavoravano in contesti non cristiani. Inoltre oggi stiamo vedendo che questa idea la stanno assumendo sempre di più anche persone di altre tradizioni religiose. E dunque se lo vediamo all’interno della missione della Chiesa, il dialogo non esclude la dimensione dell’annuncio, che è espressione di quella fede, ma non è finalizzato a un rigido proselitismo: è legato alla comunicazione d’amore, fondamento della relazione con Dio e tra di noi.
 Nel suo libro La Croce e l’Islam, appena pubblicato, scrive: «Nel dialogo interreligioso le proprie convinzioni religiose non possono essere messe tra parentesi, perché non si può tenere nascosta la parte più profonda di sé»: siamo ‘attrezzati’ – laici e religiosi – per proporre le nostre convinzioni religiose?
Nel suo libro La Croce e l’Islam, appena pubblicato, scrive: «Nel dialogo interreligioso le proprie convinzioni religiose non possono essere messe tra parentesi, perché non si può tenere nascosta la parte più profonda di sé»: siamo ‘attrezzati’ – laici e religiosi – per proporre le nostre convinzioni religiose?
Risponderei di sì, almeno come sforzo ed intenzione. È un esercizio importante la capacità di comunicare la propria fede. Tuttavia, a volte, la riteniamo un po’ in senso privato e abbiamo perso quel carattere di testimonianza che ci viene dal vangelo, sull’esempio di Gesù quando incontra le persone più diverse. Il risultato dell’annuncio è sempre un’uscita da sé. Dobbiamo essere aperti, ricettivi dell’amore di Dio. Quando ne siamo toccati solo superficialmente, solo per tradizione, allora ne deriva la tiepidezza della nostra fede, un problema per i laici come per i religiosi. Gesù incontra dei peccatori e delle peccatrici e nonostante il peso di quel peccato, quelle persone sono toccate nel profondo e scatta in loro la molla della testimonianza.
Se ci fermiamo alla superficie del dialogo, pratichiamo solo un dialogo di facciata o di cortesia. Oggi il dialogo interreligioso corre il rischio di essere strumentalizzato politicamente e io, come ripeto a tutti, non voglio cadere in questa trappola, anche se accetto di confrontarmi con tutti. Il dialogo interreligioso deve essere fondato su un dialogo “teologico” (non solo nel senso specialistico) in cui il centro è il trascendente. Il rapporto con l’altro avviene nell’ambito del dialogo interreligioso in riferimento ad un rapporto con il trascendente; è questo che ci sfida anche nella relazione. Da quale Dio partiamo?
Ecco, per tornare alla domanda, io penso che ci sono persone che sono “attrezzate” per dialogare; dobbiamo però praticare un esercizio, perché il dialogo è anche questo, un modo di essere che presuppone anche una continua conversione. Al capitolo 10 del libro degli Atti degli Apostoli si parla dell’incontro tra Pietro e il centurione Cornelio: c’è chi intitola questo capitolo “la conversione di Cornelio” mentre da qualche parte la si descrive come “la conversione di Pietro”. In realtà leggendo il testo capiamo che si tratta di un incontro frutto di una chiamata: in quella chiamata ad andare verso l’altro c’è Dio. Allora si superano i blocchi.

Io sono portato a vedere “il bicchiere mezzo pieno”, con una speranza che forse possiamo chiamare cristologica che scaturisce dalle parole di Gesù: «Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt. 28,20). In più di trent’anni di dialogo, ho avuto tante testimonianze personali e di incontri, che mi hanno aiutato a vedere come lo Spirito è al lavoro. Ci sono tanti cambiamenti nella Chiesa e anche le novità del concilio Vaticano II stanno producendo effetti. Se guardiamo la secolarizzazione nel mondo europeo, allora come cristiani siamo in effetti un po’ scoraggiati, ma non sono i numeri che alla fine contano. Forse dobbiamo abbandonare qualcosa per liberarci dalle strutture pesanti e comunicare più apertamente la nostra fede… Più dei numeri (nel senso di più partecipazione, più gente in chiesa…) mi interrogherei sul “problema” dei giovani: sono così insensibili al problema religioso solo perché non li vediamo in chiesa? Chiediamoci se il loro venire in chiesa o la loro partecipazione sia ostacolata da altri fattori. Forse li abbiamo abbandonati e, se andassimo a cercarli, in loro troveremmo sicuramente un bisogno, una nostalgia di qualcosa che manca loro anche a livello valoriale, tanto che si devono rifugiare in altri “paradisi”, per trovare un orizzonte di senso. Questo vale anche per i giovani di altre tradizioni religiose.
E non sarà certo la corsa a una presenza della Chiesa nel digitale che aiuterà a superare questo smarrimento, perché i ragazzi hanno bisogno di una umanità, smarrita soprattutto dagli adulti. Dobbiamo uscire dalle strutture centralizzate per incontrarli nelle periferie esistenziali.
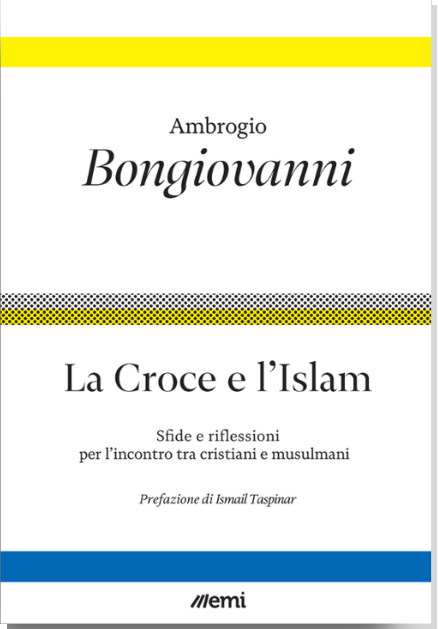
Segnaliamo il volume:
A. BONGIOVANNI
La Croce e l’Islam. Sfide
e riflessioni per l’incontro
tra cristiani e musulmani
EMI, Bologna 2024, pp. 210
