C’è uno sguardo nuovo sotto il sole
È necessario riaprire gli occhi alla valenza politica delle pagine bibliche
di Angelo Reginato
pastore battista
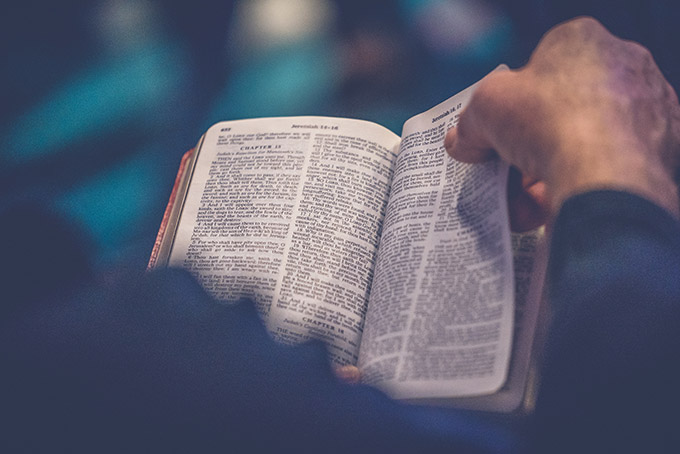 Nella biblioteca biblica, prevale il “noi” rispetto all’“io”. Fin dalla prima pagina, Dio non dà forma ad un’anima che lo desideri, ad una religione che lo celebri, ma crea un mondo.
Nella biblioteca biblica, prevale il “noi” rispetto all’“io”. Fin dalla prima pagina, Dio non dà forma ad un’anima che lo desideri, ad una religione che lo celebri, ma crea un mondo.
Un mondo plurale, abitato da diversi popoli, che parlano lingue differenti. Un mondo il cui governo Dio affida agli umani, chiamati a custodire e coltivare la terra, a dare forma a quella vita buona che Lui ha sognato “in principio”. Chi apre questo Libro, è invitato a far propria la sfida dell’imparare a leggere nientemeno che la vita: il microcosmo della nostra vicenda personale, certo, ma anche il macrocosmo della storia umana. Noi, però, leggiamo le Scritture con occhiali che non sanno più mettere a fuoco il sogno ed il compito di abitare la terra in modo divino. Il panorama che compare sotto i nostri occhi è quello dell’anima. Viviamo cioè il paradosso di avere tra le mani un testo “politico”, ma di leggerlo in tutt’altro modo. Per recuperare il lievito pubblico delle Scritture, occorre allargare l’orizzonte dell’atto di lettura, perché non si riduca ai ristretti confini dell’anima.
Leggere è abitare un mondo e non solo attingere a sentimenti che consolano. La narrazione biblica desidera accendere la passione per un mondo diverso dal nostro, il Regno di Dio. Differente ma non estraneo alla nostra storia, al punto di proporsi come suo lievito, sale e luce. Solo leggendo la Bibbia nel teatro della storia, si è in grado di abbracciarne «la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità» (Ef 3,18).
Sentire in grande
Dunque, la domanda preliminare per affrontare il nostro tema è: come leggiamo la Bibbia? E come il Libro stesso domanda di essere letto, in modo tale da suscitare conversione e aprire nuovi orizzonti? C’è stato un tempo in cui lo stile di lettura delle Scritture era caratterizzato dal “sentire in grande”. Basta sfogliare le pagine che riportano le predicazioni ed i commenti biblici dei cosiddetti padri della chiesa, ovvero di quei credenti delle prime generazioni cristiane che si sono assunti l’onere di spezzare sapientemente il pane della Parola per nutrire i cercatori di senso. Vi troviamo un’interpretazione della storia umana, compreso il presente, mai però ridotto alla stretta attualità. Ma al “sentire in grande” del momento aurorale del cristianesimo è subentrato un “sentire in piccolo”, che ha ristretto l’orizzonte biblico entro i recinti del sacro: la Bibbia parla delle cose della religione, rivolgendosi esclusivamente all’anima di chi legge.
La prima sfida riguarda i nostri occhi di lettori, prima ancora di trovare testi che ci possano far riflettere sulla dimensione politica della fede. E una volta pulito lo sguardo, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Quest’ultima sarà, per forza di cose, dettata dal presente, dalle urgenze del proprio tempo. Formulo in estrema sintesi un’ipotesi di lavoro, il mio discernimento su questo tempo: per cogliere, oggi, il potenziale politico delle Scritture, dobbiamo prestare attenzione alla letteratura sapienziale (in particolare, al Qohelet). Finora lo sguardo di chi ricercava ispirazioni per un pensiero politico a partire dalle Scritture si volgeva al fuoco della Torà e della parola profetica, che infiamma la scena solenne dell’alleanza tra Dio ed Israele.
Sapienza quotidiana
Nello sguardo sapienziale non c’è il pathos dell’ideale e nemmeno l’urgenza della redenzione. Piuttosto, si presta attenzione al quotidiano e alle necessarie competenze per muoversi nella realtà della vita. Lo sguardo si appunta in una storia concreta, particolare. E la realtà messa a fuoco dallo sguardo sapienziale non è più a tutto tondo, come nella scena iniziale, ma risulta profondamente ambigua, mutevole. Non offre stabili prospettive ideali ma domanda di passare da problema a problema. Dio non parla più con la voce tonante del Sinai. Tocca agli umani decidere quale sia la scelta adeguata alla circostanza in cui vengono a trovarsi. All’epica dei tempi fondatori e dei successivi oracoli profetici, i sapienti preferiscono una narrazione che esplori la condizione umana nei suoi diversi e contraddittori aspetti. Un po’ come il romanzo moderno, che Milan Kundera presenta in questi termini: «Mentre Dio andava lentamente abbandonando il posto da cui aveva diretto l’universo e il suo ordine di valori, separato il bene dal male e dato un senso ad ogni cosa, don Chisciotte uscì di casa e non fu più in grado di riconoscere il mondo. Questo, in assenza del Giudice supremo, apparve all’improvviso in una temibile ambiguità; l’unica Verità divina si scompose in centinaia di verità relative, che gli uomini si spartirono fra loro. Nacque così il mondo dei Tempi moderni, e con esso il romanzo, sua immagine e modello».
Pensiamo al nostro passato prossimo e a questo inafferrabile presente. Al tempo fondativo della Costituzione è seguito il tempo profetico della denuncia del suo tradimento, dell’imporsi di una costituzione materiale differente da quella scritta sulla carta; ora, anche quella stagione della contestazione sembra esaurita e ci ritroviamo a dover ripensare il senso di un’umanità smarrita. Il linguaggio solenne dei valori costitutivi, come quello militante che ha dato voce alla stagione delle lotte, sembra non parlare più alla nostra generazione. Come nel canone biblico, sorge l’esigenza di un altro linguaggio, che si smarchi dalla lingua parlata in precedenza, troppo compromessa con i sacerdoti difensori dell’istituzione e con i falsi profeti. Lo sguardo sapienziale è appuntato a quanto succede “sotto il sole”, pur sapendo che c’è anche un “sopra”, e che alla fine i giochi li farà Dio. Il presente, però, sollecita mosse parziali e, allo stesso tempo, sagge, astute, che evitino la paralisi di fronte all’immane potenza del negativo.
Scendere in piazza
La sapienza è sguardo lucido, mosso da una passione educativa. Sta qui il suo apporto principale per il nostro tempo. Perché oggi a surriscaldarsi non è solo il clima ma anche gli animi! La sapienza sa che gli occhi sono filtri, non specchi: vedono quello che vogliono vedere. Di qui l’importanza di agire a monte, sullo sguardo. E agire con scaltrezza, con un linguaggio che si sottragga al rifiuto pregiudiziale che gli esseri umani oppongono di fronte ad argomenti ritenuti scomodi. Spaventati dai sintomi di una crisi che minaccia l’esistenza sul pianeta, molti manifestano la loro preoccupazione scendendo nelle piazze (perlopiù solo in quelle virtuali, postando sui social foto, video, slogan, considerazioni varie). Anche la sapienza «grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze; nella città, la sapienza pronuncia i suoi discorsi: volgetevi ad ascoltare la mia correzione... il mio consiglio... la mia istruzione» (Prov 1,20ss). La passione politica delle Scritture, la cura per il mondo sognato da Dio, oggi, si gioca, innanzitutto, nel compito educativo di formare cittadini e ristabilire i legami, secondo la sapienza delle Scritture. Riapriamo la Bibbia non più solo nel chiuso della nostra stanzetta ma anche nel bel mezzo della piazza della nostra città!
Segnaliamo il volume:
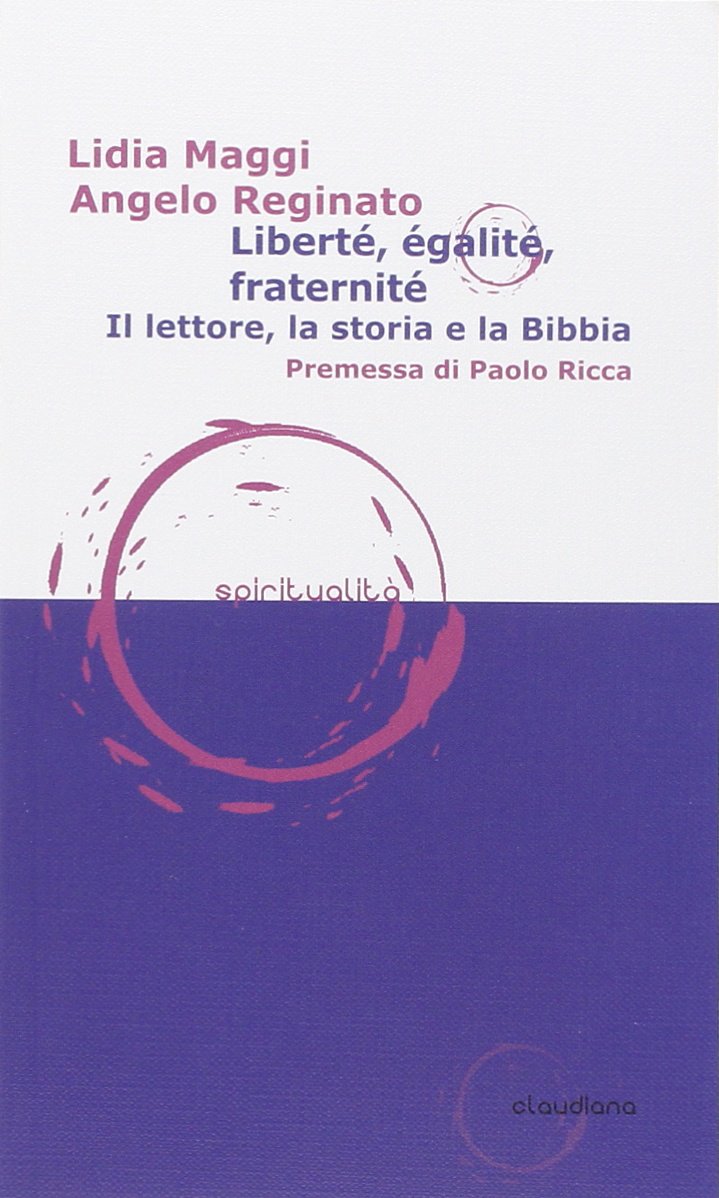
Lidia Maggi-Angelo Reginato
Liberté, égalité, fraternité. Il lettore, la storia e la Bibbia
Claudiana, Torino 2014, pp. 146
