“A ognuno il suo Dio”. È uno slogan che suona come minimo ambiguo, equivoco, soprattutto se ci mettiamo nei panni di Dio (ex parte Dei). Si fa presto a dire Dio, ma di quale Dio stiamo parlando?
Barbara Bonfiglioli
Un Dio in cui credere
La religione che professiamo brilla nella nostra capacità di accogliere
di Mario Menin
già missionario saveriano in Brasile, insegna Ecumenismo allo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia e dirige la rivista “Missione oggi”
 Pluralismo religioso
Pluralismo religioso
Parliamo del Dio di Gesù Cristo (cristianesimo) o del Dio di Muhammad (islam) oppure di Abramo e di Mosè (ebraismo)?
Allora lo slogan diventa addirittura imbarazzante, perché sembra frantumarne la misteriosa e indeclinabile unicità e universalità. Se, invece, ci mettiamo dalla parte di “ognuno” (ex parte hominis), cioè della realtà multireligiosa vissuta in Italia ed in Europa, allora forse possiamo captare in questo slogan un “segno dei tempi”, un invito a valorizzare il “pluralismo religioso” come un dono che ci interpella e ci aiuta a fare i conti con “vecchi e nuovi dei”, un dono che paradossalmente ci fa conoscere meglio noi stessi, chi siamo, nell’incontro ormai inevitabile con l’altro, il diversamente religioso, che viene a noi anche sui gommoni dei trafficanti di profughi, spogliati di tutto meno che della propria fede.
In questo senso, è molto eloquente quanto successo poche settimane fa a una famiglia di Parma, che ospita due giovani profughi africani, richiedenti asilo, con nel corpo i segni del passaggio dalla Libia. «Oggi devi pregare molto», dice la mamma Maria Chiara rivolgendosi al figlio Guido, «perché vada bene il colloquio di lavoro di Yunus» (uno dei due giovani ospiti, ambedue musulmani praticanti). «Io non so pregare Allah», ribatte Guido. «Non fa niente», conclude la mamma, «prega Gesù, perché poi si metteranno d’accordo, si passeranno la preghiera».
Sebbene di estrema attualità, la frase “a ognuno il suo Dio” mi ha all’istante rimandato indietro nel tempo, ad un altro celebre motto, quello del “cuius regio, eius religio” (un re, una religione) e alla triste storia degli Stati europei dopo l’avvio della Riforma (1517), alle prese con la diversità religiosa - cattolica e protestante - al proprio interno. La regola escludeva la mescolanza di credenti e divideva territorialmente le religioni (denominazioni cristiane): ciascuna nel proprio fazzoletto di terra e con un proprio re. La libertà e la pace potevano esistere solo tra eguali dal punto di vista religioso (le disuguaglianze sociali non contavano!). Dio - quale? Quello con la “D” maiuscola o con la “d” minuscola? - si identificava con i confini degli Stati e Chiese protestanti non erano ben viste in terra cattolica e viceversa.
 Dio è al di là dei limiti
Dio è al di là dei limiti
Si pensi alla Guerra dei trent’anni (1618-1648), in cui entrarono in gioco anche malcelati interessi politici. Con la pace religiosa di Augusta (1555), l’imperatore Carlo V aveva, sì, sancito la divisione fra territori cattolici e protestanti, ma non era riuscito a disinnescare tutte le violenze che covavano tra le diverse denominazioni cristiane. In questo caso, la formula “a ognuno il suo Dio”, per quanto politicamente realistica - consentiva agli Stati europei di non massacrarsi nel nome di un Dio o di un dogma -, decretava la sconfitta di Dio, riducendolo a realtà denominazionale, quindi parziale, indegna dei suoi attributi più nobili. «Non puoi rendere Dio cattolico», affermava il cardinale Carlo Maria Martini, «Dio è al di là dei limiti e delle definizioni che noi stabiliamo. Nella vita ne abbiamo bisogno, è ovvio, ma non dobbiamo confonderli con Dio, il cui cuore è sempre più vasto» (Conversazioni notturne a Gerusalemme).
A leggere le cronache di questi ultimi anni, soprattutto dagli attentati dell’11 settembre 2001, sembra di essere ritornati indietro di oltre quattrocento anni, quando appartenere ad una fede (denominazione cristiana) diversa da quella della maggioranza era rischioso. Oggi, però, grazie alle conquiste del movimento ecumenico del secolo scorso, non è più in questione la coesistenza dei cristiani di diversa denominazione. La furia di omogeneità oggi in Europa - non tocchiamo la questione dei paesi islamici intolleranti nei confronti di tutte le minoranze, cristiane comprese - si abbatte su alcune religioni non cristiane, soprattutto l’islam, incarnato dalla figura dell’immigrato, colpevole di tutti i mali della società che lo accoglie. La Svizzera, per esempio, ha decretato per referendum che chi vive sul suolo elvetico può o non può pregare pubblicamente. Nell’iniziativa referendaria del 29 novembre 2009 i cittadini della Confederazione hanno messo al bando la costruzione di minareti (solo 4 dei 26 cantoni si sono opposti all’emendamento costituzionale). E pensare che al momento del voto esistevano solo quattro minareti in Svizzera.
L’unica cosa seria è accogliere
Grazie a Dio - è proprio il caso di dirlo - i vescovi cattolici si sono pronunciati in favore della libertà di religione, anche se si sono in qualche modo macchiati di complicità nei confronti della vecchia logica di “un re, una fede” quando hanno accettato che politici ticinesi decidessero che il crocifisso è un simbolo culturale dell’etnicità (nazionalità) italiana. Anche una Regione italiana, la Lombardia, ha rispolverato la vecchia logica “un re, una fede”, emanando nel gennaio 2015 la Legge n. 62, meglio conosciuta come provvedimento anti-moschee, accostando la diversità religiosa con un approccio etnico-tribale non contemplato dalla nostra Costituzione. La logica è ancora quella della colpevolizzazione del diverso, che viene al massimo tollerato o ghettizzato (si pensi alla sorte delle storiche minoranze religiose in Italia, quella valdese e quella ebraica).
Se la formula “cuius regio, eius religio”, coniata quattro secoli e mezzo fa, servì a pacificare un’Europa divisa tra protestanti e cattolici, in attesa del ritorno all’unità cristiana, oggi, come cristiani europei, siamo chiamati ad abitare in maniera nuova il continente (e il mondo), in dialogo costante con le diverse culture e religioni, anche per discernere meglio l’unicità e la specificità della missione cristiana, come continuazione di quella di Gesù Cristo. Il brutto gioco della pulizia etnica e religiosa, che ha ammorbato l’Europa del Novecento e che piace a certi populismi nostrani, non per devozione religiosa, ma per una fanatica interpretazione dell’identità collettiva, va senz’altro sostituito dagli atteggiamenti dell’accoglienza e dell’ospitalità, affinché a ognuno sia possibile professare la sua fede e rendere culto al suo Dio.
È l’unico spettacolo serio che l’Europa può offrire al mondo, anche in nome della sua tradizione cristiana. Meno di un secolo fa l’ubriacatura di omogeneità razziale e religiosa fece del vecchio continente un mattatoio, oggi le Chiese cristiane in Europa sono chiamate a far risplendere il vangelo di Gesù Cristo attraverso l’accoglienza e l’ospitalità. «Se non si vuole giungere a nuovi scontri, occorrerà promuovere con forza un serio e corretto dialogo interreligioso» (Carlo Maria Martini).
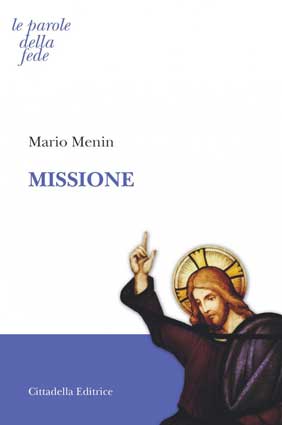
Dell’Autore segnaliamo:
Missione
Cittadella, Assisi 2016, pp. 176
