L’Economia dell’ospitalità
Sguardo sulle dinamiche della storia alle prese con la globalizzazione
di Stefano Zamagni
economista
 Ricchi contro poveri
Ricchi contro poveri
È vero che i flussi migratori sono vecchi almeno quanto l’umanità stessa, ma viviamo in un’epoca in cui i movimenti delle persone da un paese all’altro mai avevano conosciuto l’intensità e la problematicità di questi tempi.
Una prima res nova concerne il paradosso sconcertante dell’attuale fase storica: la globalizzazione economica, mentre accelera e magnifica la libertà di trasferimento di beni e di capitali, va ostacolando, in modo esplicito e più spesso implicito, i movimenti delle persone, mettendo a repentaglio la fruizione di quel diritto fondamentale dell’uomo - da tutti riconosciuto - che è la libertà di movimento. In altri termini, in un’epoca come l’attuale in cui la cultura del mercato si va generalizzando e va entrando in tutti i domìni della vita associata, dovrebbe sembrare normale vedere nel fenomeno migratorio una risorsa per forme più avanzate di progresso umano. Ed invece quando quella stessa cultura di mercato viene applicata ai movimenti delle persone, i termini che più ricorrono sono quelli dell’espulsione, del razionamento degli ingressi, dei permessi speciali.
In verità non è difficile scoprire la radice di tale asincronia di atteggiamenti. Impedimenti e ostacoli ai movimenti delle persone non si applicano a tutti i migranti indistintamente, ma solo a coloro che, provenendo da certe aree geografiche, sono portatori di specifici bisogni. È questa una manifestazione tipica della cosiddetta “sindrome di Johannesburgh”, secondo la quale i “ricchi” devono iniziare a difendersi dai “poveri”, riducendo o ostacolando i loro spostamenti. Una nuova retorica si va così diffondendo a livello culturale: i migranti come responsabili delle crisi sociali e delle nuove paure collettive e come minaccia seria alla salvaguardia delle identità nazionali.
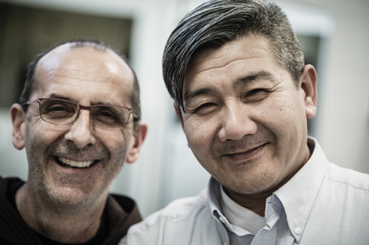 Universi culturali distanti
Universi culturali distanti
Una seconda novità è rappresentata dalla consapevolezza, ormai diffusa anche tra i non addetti ai lavori, che nell’epoca della “nuova economia” i flussi migratori sono destinati ad aumentare per ragioni strutturali che ben poco hanno a che vedere con quelle che tradizionalmente hanno spiegato le migrazioni del passato. In altro modo, le nuove tecnologie infotelematiche e la creazione di un mercato del lavoro globale stanno provocando profonde trasformazioni nei flussi migratori internazionali e ciò nel senso che vanno mutando sia i fattori attrattivi (pull) sia quelli di espulsione (push). Talvolta è dato di leggere che parecchi sarebbero i punti che accomunano le odierne migrazioni e le prime emigrazioni di massa del XIX secolo. Viene ricordato, infatti, che nell’800, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, circa 52 milioni di europei emigrarono dai loro paesi d’origine e di questi ben 34 milioni scelsero gli USA. Il celebre Passenger Act, votato dal Parlamento di Westminster nel 1803, incoraggiava l’emigrazione verso le ex colonie inglesi.
Fino al 1860, il 66% degli emigrati europei verso le Americhe e l’Oceania proveniva dalla sola Gran Bretagna e il 32% dalla Germania. Quest’ultima divenne poi importatrice netta di forza lavoro verso il 1880. Se informazioni del genere vanno tenute in debita considerazione per non ingigantire oltre misura le differenze tra la situazione di allora e quella attuale, si devono al tempo stesso riconoscere i forti elementi di discontinuità. Uno di questi è che l’introduzione delle nuove tecnologie nei processi produttivi, mentre ha reso più vicini paesi tra loro spazialmente lontani, non ha affatto eliminato, anzi ha ampliato, le distanze in termini culturali. E non v’è chi non veda come il nesso tra universi culturali e impiego di nuove tecnologie divenga di centrale importanza nei processi di integrazione sociale. Fino a che si chiede all’immigrato di svolgere compiti di mera routine o di adempiere operazioni puramente meccaniche, la distanza culturale tra i mondi di provenienza e di arrivo non si fa sentire. Non così, invece, quando, per inserirsi vantaggiosamente nell’attività lavorativa, l’immigrato deve acquisire, facendoli propri, schemi logico-organizzativi che postulano il riferimento ad una ben definita matrice culturale. In buona sostanza, l’inserimento dell’immigrato in società tecnologicamente avanzate pone problemi di gran lunga più delicati rispetto a quelli del passato, anche recente.
Un altro elemento di profonda differenziazione tra le migrazioni odierne e quelle di ieri è che non pare suffragata dai fatti la tesi, di moda fino agli anni ’80, secondo cui lo strumento più efficace per allentare la pressione migratoria sarebbe quello di accrescere le potenzialità occupazionali nei paesi in via di sviluppo. Se tale argomento fosse corretto, basterebbe allora suggerire a questi paesi l’adozione di tecniche ad alta intensità di lavoro per arrestare, o quanto meno ridurre, l’entità dei flussi migratori. Ma le cose non stanno in questi termini. In primo luogo, perché nei paesi in via di sviluppo l’emigrazione, anziché rappresentare un’alternativa al processo di sviluppo, costituisce oggi un mezzo per avviare tale processo. E ciò sia perché le rimesse degli emigrati consentono di far giungere risorse finanziarie direttamente nelle mani dei potenziali utilizzatori senza passare per l’intermediazione dello Stato o delle agenzie pubbliche sia perché l’emigrazione costituisce il modo più rapido e meno costoso per un paese povero di entrare in possesso delle abilità e delle conoscenze richieste dai nuovi paradigmi tecnologici. Inoltre, durante i primi stadi del processo di sviluppo, si generano incentivi specifici all’emigrazione. Infatti, l’aumento delle ineguaglianze socio-economiche che sempre accompagna le fasi iniziali del processo di crescita spinge segmenti crescenti di popolazione a prendere la via dell’emigrazione. Come la new economics of migration ha chiaramente illustrato, la decisione di emigrare va interpretata come strategia di diversificazione dei rischi: alcuni membri della famiglia emigrano per consentire a coloro che restano in patria migliori prospettive di vita. In definitiva, sarebbe vana illusione pensare di arrestare i flussi migratori, almeno nel breve e medio periodo, semplicemente puntando sull’avvio di processi di sviluppo nei paesi generatori degli stessi. Lo sviluppo è bensì necessario ma non certo sufficiente a neutralizzare le spinte all’emigrazione nel breve e medio periodo.
 Dove nasce la paura
Dove nasce la paura
Alla luce di quanto precede, riusciamo a darci conto del sentimento di irrazionale paura che pervade le nostre popolazioni europee - si consideri che l’Unione Europea è la prima destinazione al mondo dei flussi, davanti a USA, Paesi del Golfo e Russia -: la paura è che le nostre società si dimostrino incapaci di governare flussi crescenti di migranti portatori di culture affatto diverse dalle nostre. E di fronte alla paura, l’atteggiamento che prevale è quello della chiusura, del nascondere “la polvere sotto il tappeto” per esimersi dall’affrontare in modo originale un problema di portata epocale. Sappiamo tutti che i grandi flussi sono alimentati da tre principali cause: l’evoluzione demografica (l’Eurostat ci informa che l’aumento della popolazione europea over 65 e la diminuzione di quella della fascia di età 15-64 produrrà un aumento progressivo del tasso di dipendenza degli anziani dal 28% attuale al 50% alla metà del secolo); le disuguaglianze economiche, sia di reddito sia di ricchezza; la instabilità politica.
In questi ultimi anni sono però le guerre civili e la violenza politica a costituire la prima causa delle partenze forzate - si pensi a Eritrea, Somalia, Siria, Iraq, Libia. Ma già sappiamo che nei prossimi anni gli effetti del cambiamento climatico sulla riduzione delle terre abitabili farà emergere una nuova categoria di migranti, i cosiddetti “rifugiati ecologici” - espressione per primo coniata da Lester Brown nel 1976. Le Nazione Unite hanno di recente stimato che nel prossimo quindicennio si conteranno cinquanta milioni di rifugiati climatici. Inoltre, potenti forze politiche e agguerrite lobbies economiche stanno contribuendo a dare vita a nuove dinamiche di espulsione. Alludo al fenomeno, in costante aumento, del land grabbing (accaparramento delle terre), cioè alla sottrazione di terre fertili ai loro abitanti da parte di governi stranieri e di grandi multinazionali, soprattutto in Africa subsahariana, per soddisfare la domanda interna di prodotti agricoli e per produrre energia. Nel Rapporto del Parlamento Europeo Addressing the Human Rights Impacts of Land Grabbing (2014) si riconosce bensì come tali appropriazioni comportino patenti violazioni dei diritti umani, ma nulla si propone per fermare un tale crimine.
L’ipocrisia della politica
Di fronte ad uno scenario del genere non ci si può non indignare per l’ipocrisia e per l’inadeguatezza delle politiche migratorie dell’UE, che non vanno oltre l’adozione di pratiche meramente assistenzialistiche che, umiliando coloro che ne sono i destinatari, alimentano odi e strategie di vendetta. Si consideri ad esempio quel che interessate campagne mediatiche vanno diffondendo nel nostro paese. “I musulmani ci invadono”, mentre meno di un terzo degli immigrati che giungono in Italia sono musulmani. “Gli immigrati ci tolgono ricchezza”, ma in verità con i cinque miliardi di differenza tra i contributi versati dagli immigrati e i contributi percepiti da costoro, l’INPS paga le pensioni di 600 mila italiani. “Rischiamo una catastrofe demografica”, ma è vero che nel 2015 l’Italia ha perso 180 mila italiani rimpiazzati da meno di 40 mila stranieri immigrati. “Gli immigrati ridurranno le nostre possibilità di crescita futura”, mentre è vero che con più anziani e meno forza lavoro giovane si produce meno e a tassi di produttività decrescenti. (Se Angela Merkel ha deciso di accogliere, nell’agosto 2015, i migranti provenienti dalla Siria, lo ha fatto non perché guidata da una etica superiore a quella degli altri governanti, ma perché ha pensato - come un vero statista sempre dovrebbe fare - al futuro del suo paese. Diceva il nostro De Gasperi che la differenza tra un politicante ed uno statista è che quest’ultimo pensa al bene delle generazioni future; il primo invece pensa a vincere le prossime elezioni). “I migranti, oggi, sono il cavallo di Troia del terrorismo in Europa”, ma la realtà è che la quasi totalità delle persone che scappano dai loro paesi d’origine scappa dal terrore e dalle guerre.
Jean Daniélou, celebre teologo e filosofo francese, ha avanzato una riflessione afferente e illuminante: “La civiltà ha fatto un passo decisivo, forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero da nemico (hostis) è diventato ospite (hospes)”. È veramente triste constatare quanto spesso oggi - addirittura tra i cristiani o tra chi si professa tale - questa verità venga rimossa e perfino rovesciata per meschine ragioni di parte o per irresponsabile ignoranza dei fatti. Si pensi solo all’ipocrisia dei governi europei che, mentre vogliono godersi tutti i vantaggi del mercato unico, della libera circolazione di merci e capitali, non vogliono rinunciare alle proprie prerogative su difesa, sicurezza, servizi di intelligence, né vogliono accettare regole comuni su immigrazione e modelli di integrazione socio-culturale.
