A piedi nudi, a testa in giù
Entrare nelle periferie con rispetto e disposti a cambiare prospettiva
di Cristina Simonelli
dal 1976 al 2012 è vissuta in un campo Rom, prima in Toscana, poi a Verona; ora è docente di teologia patristica a Verona e a Milano
Di certi viaggi, ci ricorda Maria Zambrano, si sa solo al ritorno.
Ma, vorrei aggiungere pensando anche a certe dinamiche sulla lentezza di comprensione dei discepoli fin nel cuore dei Vangeli, un viaggio solo non basta, a ogni ritorno sono chiesti passi o almeno sguardi che scrutino nuovamente l’orizzonte. Così è stato certamente per quelli che, messisi a seguire Gesù, si sono sentiti chiedere: che cosa cercate? A propria volta hanno domandato: Rabbi, dove abiti? (Gv 1,35–39). Al vertice poi della narrazione del Quarto vangelo, la domanda diventa “chi cerchi” e la risposta è frutto di una lunga strada, Rabbunì – maestro mio (Gv 20,15–16). Arrivo? No, piuttosto sosta per nuovi inizi. Tutte e tutti ancora per strada.
 Parlare con cautela
Parlare con cautela
Quella strada che hanno fatto, Maria di Magdala con altre e altri, la conosciamo, almeno nei punti salienti, perché loro hanno saputo parlarne, raccontarla. Io provo però una profonda ritrosia a dire del lungo tempo che ho avuto la fortuna di passare in contesto Rom – trentasei anni “come un giorno, come un’ora di veglia nella notte” (Sal 90,4) – e che continua tuttora nell’amicizia, sia pure con un’altra forma di abitazione e frequentazione. Perché raccontare è importante, specialmente se dà parola a luoghi male interpretati o misconosciuti: «È questa la disgrazia che abbiamo noi, in paesi tanto poveri e isolati, signore, signor gabelliere, o come Sua Grazia si chiama: succedono cose del genere e poi non abbiamo mai chi le racconti!» (Maria Zambrano, Delirio e destino, p. 275).
E tuttavia è rischioso, perché corre il pericolo del voyerismo, dello sguardo impudico che cerca particolari piccanti, o anche semplicemente dell’esproprio della parola altrui, parlando al posto di chi viene narrato. E, altra tentazione della testimonianza, può trasformarsi in una gigantografia del narratore, che si erge sulle macerie della miseria che racconta. I/le testimoni sono chiamati a caratterizzarsi invece per l’implicazione – non spettatori, ma persone coinvolte nelle vicende – e insieme tuttavia per il decentramento, non collocandosi cioè al centro della scena o anche solo permettendo che altri lo facciano.
Provare a esprimere le ragioni di questa reticenza consente però anche di dire qualcosa di una “grazia di stato”, in questo caso in senso etimologico: la grazia di un modo di stare, di abitare. Che si fa con i piedi, ma anche con gli occhi. E che si deve provare a raccontare con le parole, ma anche condividendo uno sguardo pulito e largo, come ben esprime Livia Chandra Candiani: «[desiderio che] il gioco fra sfondo e figure si facesse più ampio e vario, in modo da non lasciar fuori scena nessuno, in modo da non trattare nessun attimo come un attimo qualunque» (Sogni del fiume, p. VI).
Levare i calzari
Questa è dunque, mi sembra, la prima cosa che si tenta di fare “uscendo” – teniamo pure provvisoriamente il termine “periferie”, su cui torniamo prestissimo. Perché possiamo poi indicare altri passaggi di metodo, ma c’è un atteggiamento previo, tanto antropologico che spirituale (due facce della stessa medaglia) che dico ora con un testo biblico, quello del roveto che “brucia e non consuma” di Esodo. A Mosè che sta di fronte a una cosa da poco, quanto può essere un arbusto, viene chiesto “togli i calzari perché questa è terra santa” (Es 3,5). Gli anni, i giorni le ore, le parole scambiate e i gesti condivisi sono poi il fuoco che brucia e illumina, ma i calzari vanno levati prima, altrimenti non si vedrà nulla o meglio si vedrà tutto in maniera distorta. Credo di poter dire che molte cose e persone della mia vita mi hanno aiutato ad avvicinarmi, come se fosse l’unica cosa giusta da fare, levando i calzari. Devo anche dire di aver incontrato tante persone – di buona volontà, senza dubbio – che sono andate ma non tutte con la stessa modalità: alcune con il gusto di imparare e capire, altre già pensando di sapere tutto e dunque “sovrascrivendo” le vite e i contesti. La doppia tipologia non si divide fra credenti e non credenti, ma tra “rispettanti e non rispettanti”, se così si può dire. È infatti assolutamente mescolata, dipende da uno sguardo previo che indirizza sia le azioni di solidarietà che lo studio o la semplice presenza. Certo, poi segue la cura di sé, delle “squadre” e dei processi: Pinuccia, che vi ha vissuto a lungo e ha “concluso la sua corsa” alcuni anni fa, lo esprimeva parlando “di relazioni rispettose” (Giuseppina Scaramuzzetti, “Costruire significative relazioni”, in Una storia tante vite. Vivere con i Rom: un libro per capire, pp.126–131).
Credo di poter dire che molte cose e persone della mia vita mi hanno aiutato ad avvicinarmi, come se fosse l’unica cosa giusta da fare, levando i calzari. Devo anche dire di aver incontrato tante persone – di buona volontà, senza dubbio – che sono andate ma non tutte con la stessa modalità: alcune con il gusto di imparare e capire, altre già pensando di sapere tutto e dunque “sovrascrivendo” le vite e i contesti. La doppia tipologia non si divide fra credenti e non credenti, ma tra “rispettanti e non rispettanti”, se così si può dire. È infatti assolutamente mescolata, dipende da uno sguardo previo che indirizza sia le azioni di solidarietà che lo studio o la semplice presenza. Certo, poi segue la cura di sé, delle “squadre” e dei processi: Pinuccia, che vi ha vissuto a lungo e ha “concluso la sua corsa” alcuni anni fa, lo esprimeva parlando “di relazioni rispettose” (Giuseppina Scaramuzzetti, “Costruire significative relazioni”, in Una storia tante vite. Vivere con i Rom: un libro per capire, pp.126–131).
Sembra una prospettiva minimalista, ma è un principio decisamente sovversivo. Del resto in Fratelli tutti si dice che «demolire l’autostima di qualcuno è un modo facile per dominarlo» (n. 52). Questo dominio non accade sempre su uomini e donne Rom, che hanno una grande forza culturale e, mediamente, anche personale e dunque una grande energia di resistenza, a volte interpretata da alcuni come riottosità inguaribile. Certamente, tuttavia, andare senza stima è un modo sicuro per fallire nel rapporto, con chiunque e dunque anche nelle cosiddette “periferie”.
Rifare le mappe
Da quanto detto, già si capisce che dall’ambiente Rom, come da molte altre “periferie”, viene anche un invito deciso a riconsiderare i nostri posizionamenti, esattamente come è accaduto con il linguaggio di anni fa sulla necessità di “ripartire dagli ultimi”. Sia l’uscita verso le periferie che l’idea di ultimi hanno ragioni e legittimazioni, perché i luoghi in cui si decide per/sugli altri, sia nella politica che nella vita ecclesiale, sono altri e possiamo anche indicarli come centri. Il primo segnale buono di un “viaggio di ritorno” è quello di mettere in discussione almeno in parte questo linguaggio: la stima sincera per le “periferie” e per la visione del mondo e del Vangelo che ci offrono porta a dire che dobbiamo cambiare questa visione e pensare quei luoghi come possibili centri. Questo movimento porta infatti a mettere in discussione ogni visione gerarchizzata del mondo: siamo una realtà poliedrica e anche policentrica. I piedi nelle “periferie” cambiano lo sguardo anche sul preteso centro e lo invitano a decentrarsi. Ogni persona è unica, speciale, inestimabile, come la rosa del Piccolo Principe.
Con questo non voglio fare affermazioni romantiche: la calma serve per non imporre i nostri modelli di vita, ci sono però necessità, bisogni, in qualche caso anche emergenze. Rispetto a tutto questo è importante piuttosto agire con prontezza, a tutti livelli, anche pubblici e politici, “una persona alla volta”, secondo usava dire Gino Strada. È esperienza comune, tuttavia, che tante volte – troppe – confondiamo i due movimenti e siamo velocissimi a giudicare e dire cosa dovrebbero fare le persone di cui riteniamo di doverci “occupare”, mentre siamo lenti se non immobili rispetto alle loro effettive esigenze. Porsi il problema, tuttavia, è già mettersi in viaggio col piede giusto.
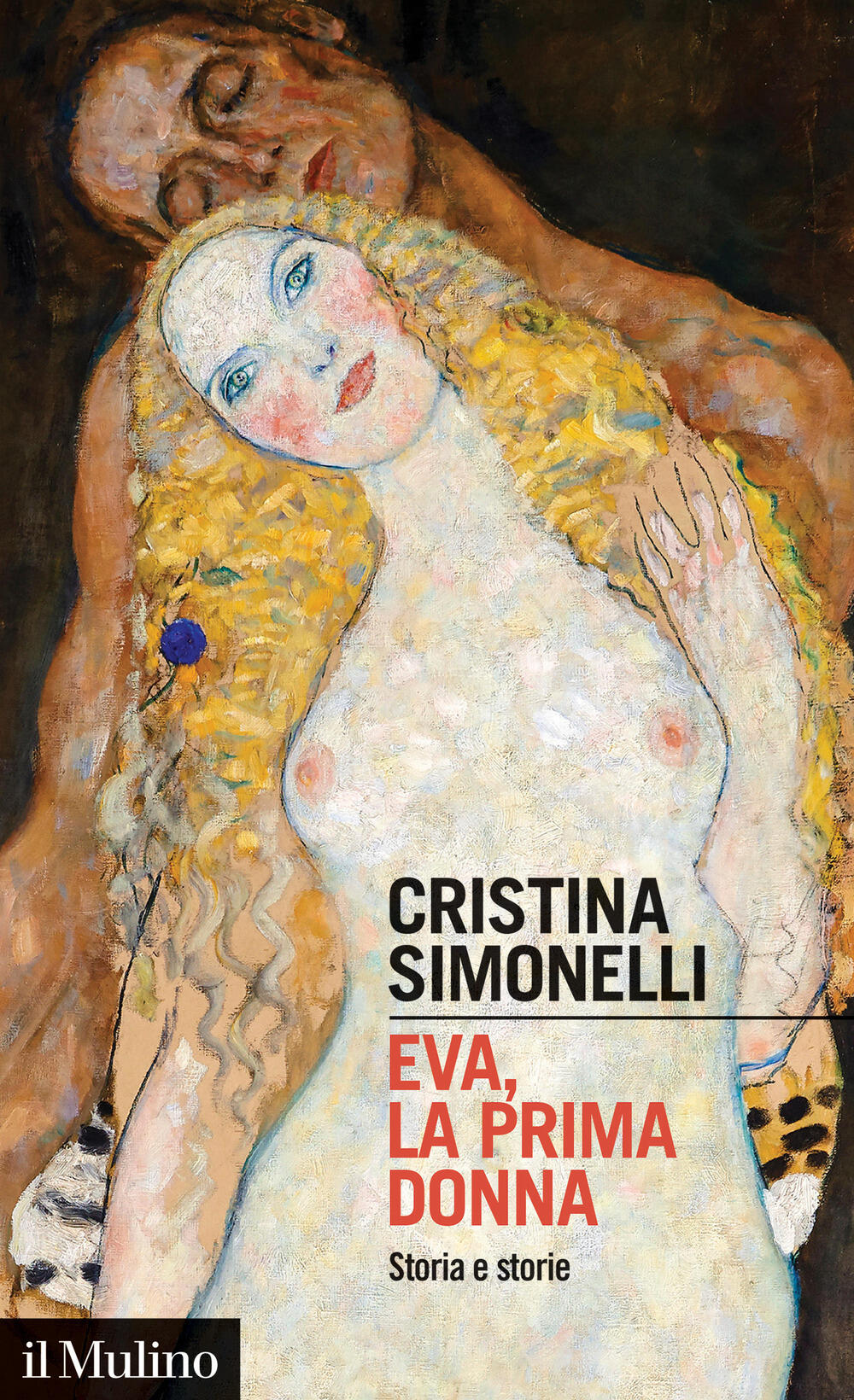
Dell’Autrice segnaliamo
Eva, la prima donna. Storia e storie
Il Mulino, Bologna 2021
